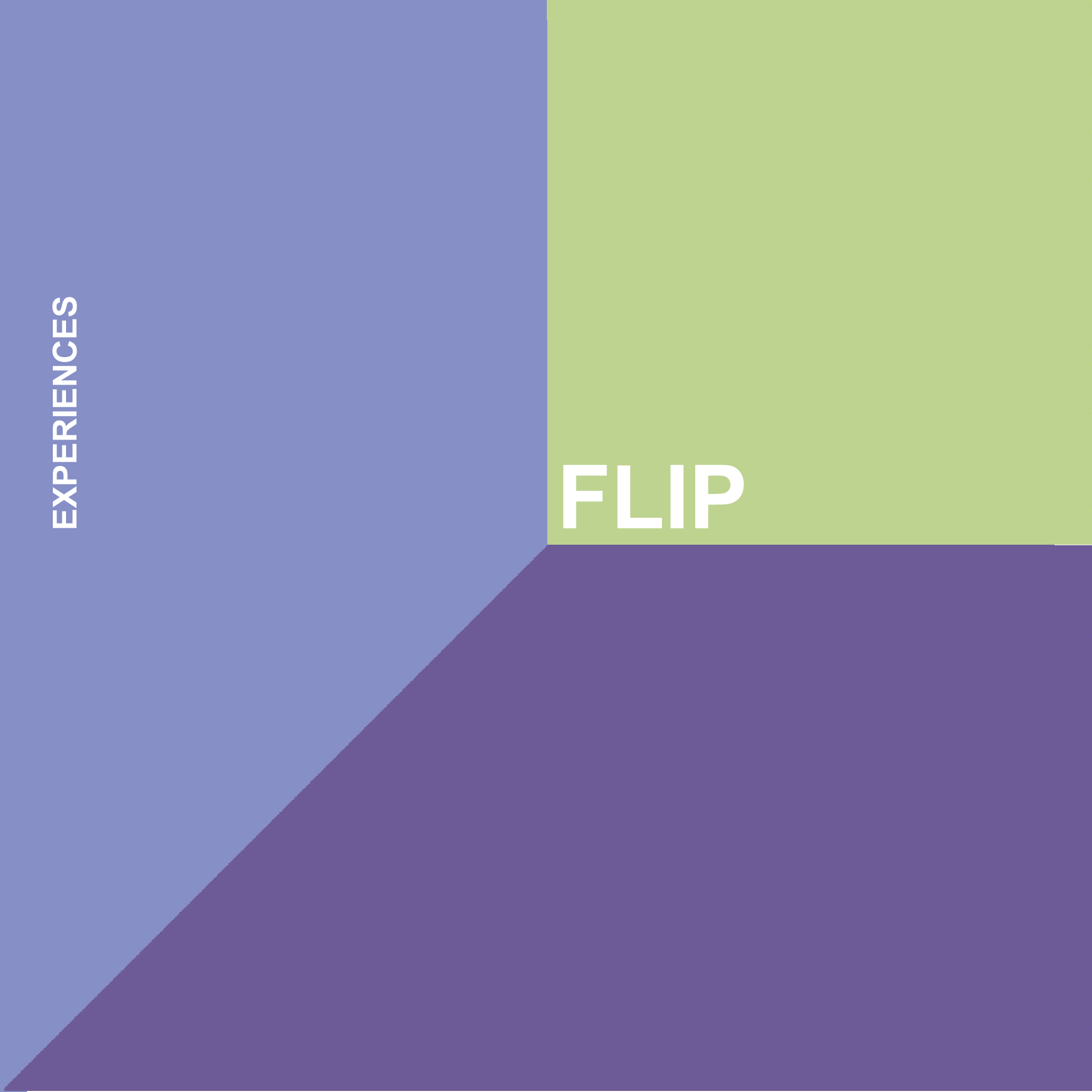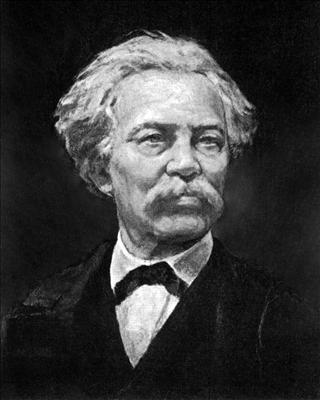Qualcuno domanderà notizie sull’identità della misteriosa Vivian Maier. Altri risponderanno che la conoscono come una bambinaia di Chicago che portava a spasso i frugoletti che le erano stati affidati e, mentre vagava per la città, scattava in continuazione fotografie. Qualche volta uno scatto la ritraeva riflessa in una vetrina, qualche altra volta i soggetti erano gli stessi bambini, ma solitamente erano scene di vita cittadina, riprodotte in bianco e nero. Immagini che nessuno conosceva fino al momento della loro scoperta in un armadio, apparentemente abbandonato. Immagini che neppure lei osservato, se non attraverso il suo obiettivo fotografico al momento dello scatto, visto che da quell’armadio sono emersi centinaia di rullini fotografici mai sviluppati e stampati. Ma quando finalmente le immagini videro la luce rivelarono una eccezionale e (forse) inconsapevole “fotografa di strada” che aveva ritratto l’America del XX° secolo. Michele Smargiassi sul Venerdì di Repubblica riassume la storia della scoperta in poche righe: «Nel 2007 un agente immobiliare di nome John Maloof si imbatte casualmente nella vendita all’asta del contenuto di un magazzino, acquista scatoloni pieni di fotografie, trova che siano capolavori, scopre su Google che l’autrice, una tata di Chicago con l’hobby della fotografia, è morta qualche giorno prima, pubblica degli esempi sul web, e il mondo s’inchina commosso e stupefatto a un genio sconosciuto».
Il nome di Vivian Maier da un giorno all’altro, grazie ad internet, è diventato famoso in tutto il mondo; molti apprezzarono così il suo lavoro meticoloso di ripresa fotografica, che la portò alla celebrità. Lei, al contrario, non se lo sarebbe mai immaginato. Pamela Bannos, docente di fotografia alla Northwestern University, trasformatasi nella sua biografa americana, l’ha ritratta in modo scrupoloso, raccogliendo le poche notizie possibili ed esaminando gli scatti. Il libro si intitola “A Photographer’s Life and Afterlife”, come dire la vita conosciuta – raccontata dai suoi stessi frugoletti divenuti oggi giovanotti e signorine in carriera – e quella dell’aldilà, cioè quel limbo di misteriosa ed oscura esistenza che la stessa Maier, consapevolmente, ha voluto occultare. La cosa più importante, sostiene la professoressa Bannos, è che la Maier non era una babysitter che studiava per diventare fotografa, ma una vera fotografa che si manteneva come babysitter per vivere. Per cui la tesi del libro è smontare tutta quella mitologia creata dai Social Network e dimostrare il lavoro coscienzioso che nessuno ha potuto esaltare quando la Maier era in vita. Questo per il fatto che la stessa Maier ha scelto di non mostrare il proprio lavoro. Il motivo? Probabilmente perché pensava che negli ambienti della fotografia d’arte (e non commerciale) i giochi fossero già fatti.
VIVIAN MAIER (New York, 1º febbraio 1926 – Chicago, 26 aprile 2009) è stata una fotografa statunitense, della cui attività artistica si sapeva ben poco fino a pochi anni prima della sua scomparsa. Vivian Maier e, soprattutto, la sua vasta quantità di negativi è stata scoperta nel 2007, grazie alla tenacia di John Maloof, anche lui americano, giovane figlio di un rigattiere. Nel 2007 il ragazzo, volendo fare una ricerca sulla città di Chicago e avendo poco materiale iconografico a disposizione, decise di comprare in blocco per 380 dollari, ad un’asta, il contenuto di un box zeppo degli oggetti più disparati, espropriati per legge ad una donna che aveva smesso di pagare i canoni di affitto. Mettendo ordine tra le varie cianfrusaglie (cappelli, vestiti, scontrini e perfino assegni di rimborso delle tasse mai riscossi), Maloof reperì una cassa contenente centinaia di negativi e rullini ancora da sviluppare. (Da Wikipedia, l’enciclopedia libera).