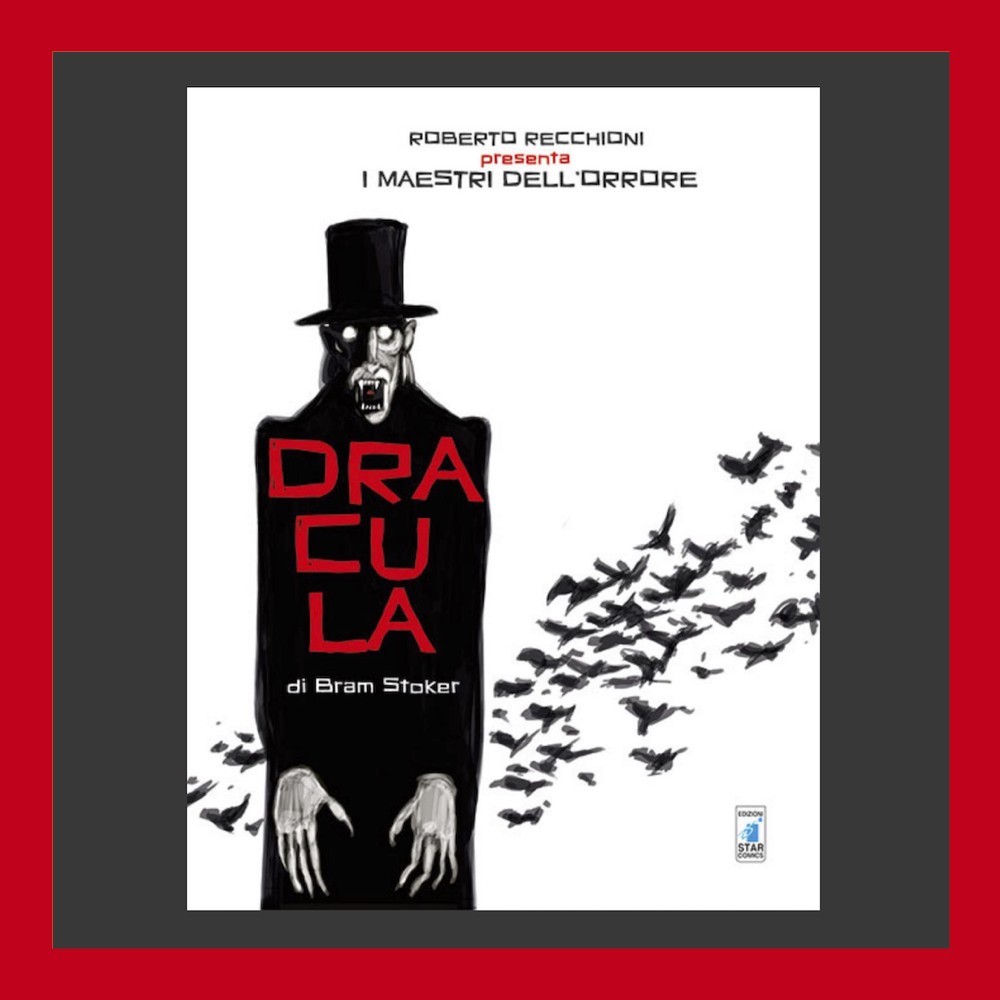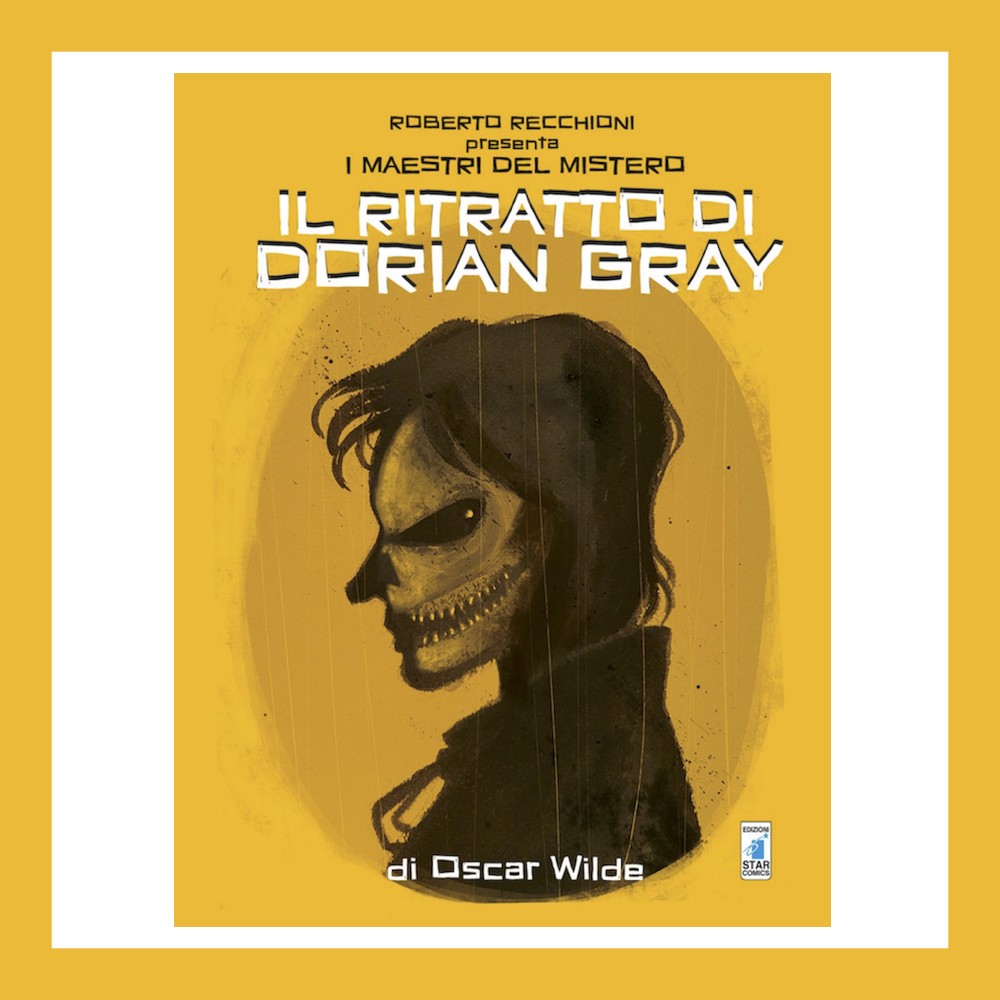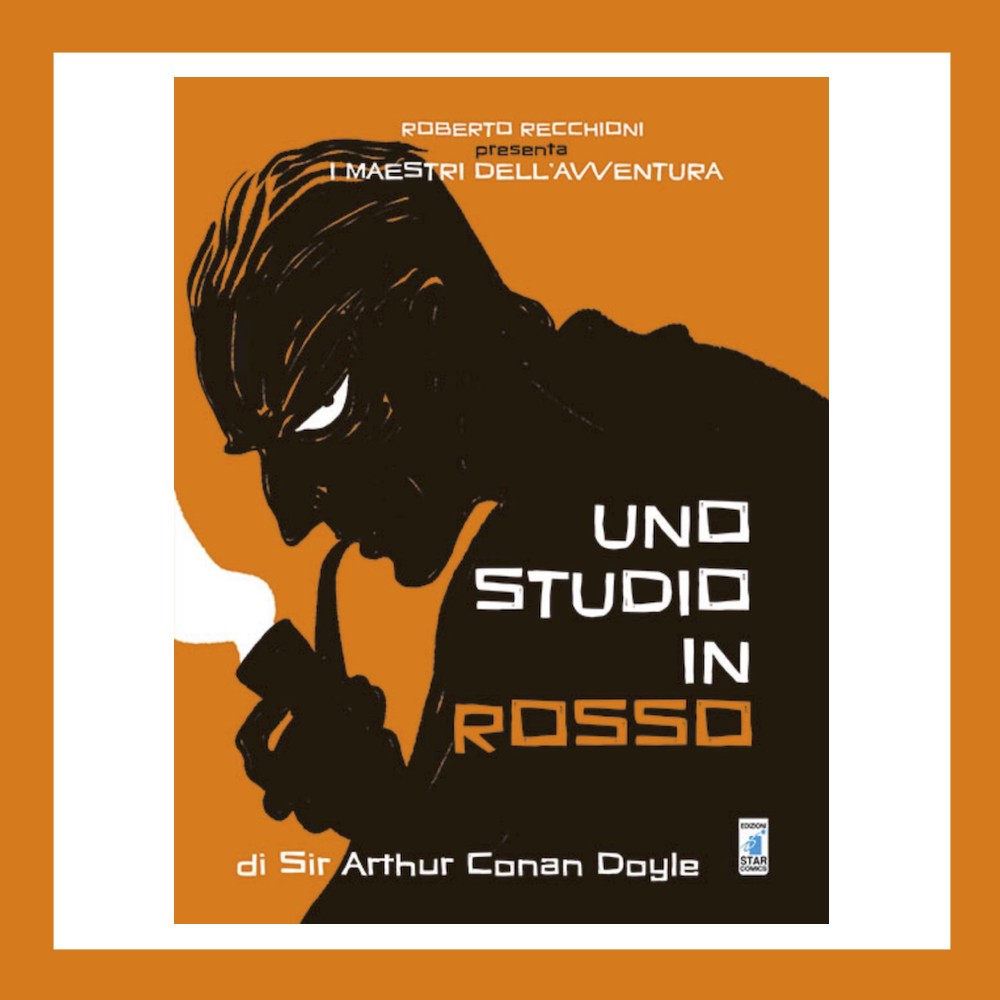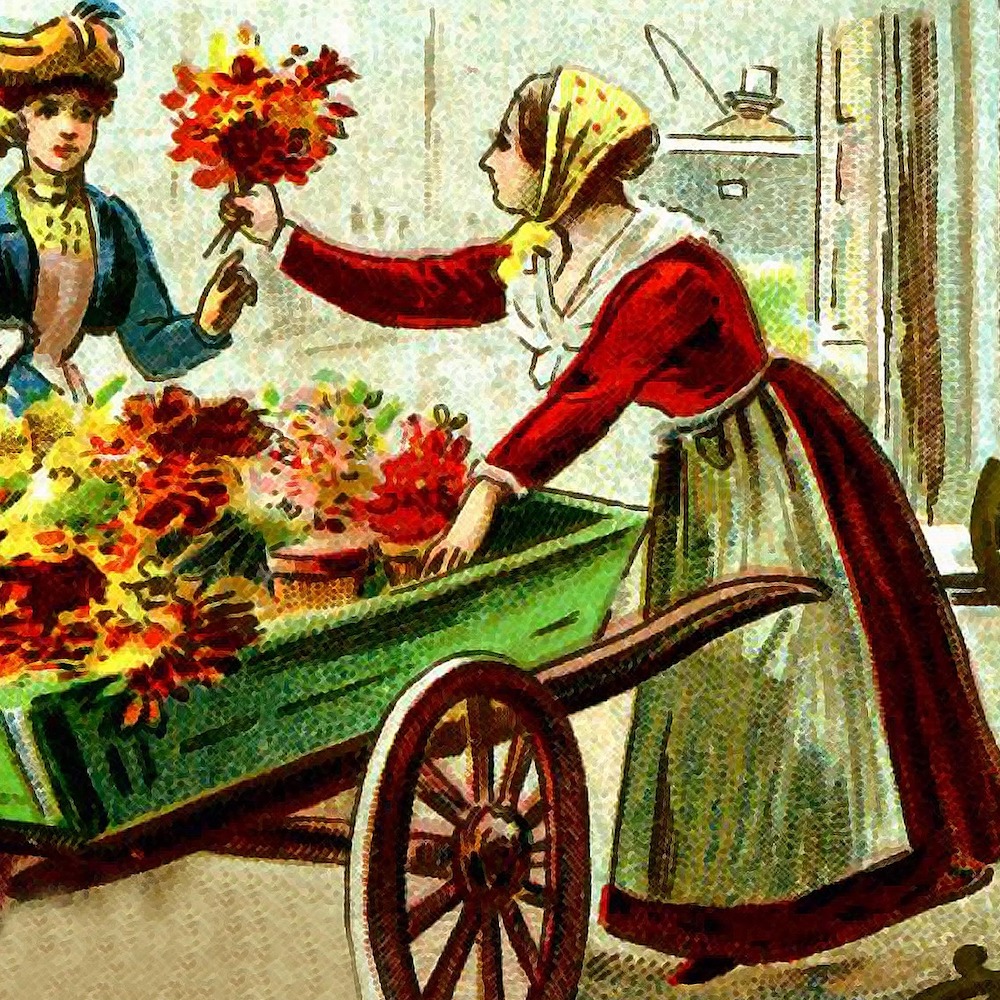A cura di Sergio Bertolami
Aldo Grasso, critico televisivo del Corriere della Sera (i cui interventi dovrebbero comparire più spesso in prima pagina) ha pubblicato nella sua rubrica un acuto commento riguardante “I talk e i dubbi sulla classe dirigente”. Qui paragona certe sconclusionate affermazioni a quelle descritte nell’Ottocento da Guy de Maupassant nel libro di racconti Le Domeniche di un borghese parigino, dove dominano stupidità e luoghi comuni. Mi è sembrato interessante, perciò, riprendere e pubblicare proprio questo simpatico brano al quale fa riferimento, ricorrendo ad una mia traduzione, per rendere comprensibile a tutti il testo originale in francese. Questi racconti sono apparsi in serie nel 1880 su Le Gaulois, giornale col quale lo scrittore aveva iniziato a collaborare inviando un pezzo a settimana. Maupassant avrebbe preferito non riunirli in volume. Fu, quindi, soltanto dopo la sua morte che apparvero in un’edizione illustrata del 1901. Les Dimanches d’un bourgeois de Paris esprime la critica al conformismo, a un modo di pensare che rasenta la stupidità, caratteristica spesso attribuita della borghesia nel XIX° secolo. Cosa fa un piccolo borghese la domenica? Stare inattivo, significa annoiarsi. Così il protagonista di questa bella serie di “avventure” – M. Patissot, cinquantadue anni, impiegato ministeriale – decide di andare a prendere un po’ d’aria fresca, tanto più che il suo medico gli ha prescritto l’esercizio fisico. In questo episodio si reca in campagna, per esempio, in un sobborgo parigino ancora relativamente sconosciuto ai lettori del tempo, ma presto dipinto anche dagli Impressionisti, tra pranzi sull’erba, balli popolari, pesca e canottaggio. Ogni domenica per il nostro piccolo borghese è una vera spedizione per incontrare personaggi che, a quanto pare, noi possiamo incrociare anche oggi, col telecomando davanti al televisore o dialogando sui social media. Buon divertimento.
LEGGI L’ARTICOLO DI ALDO GRASSO SUL CORRIERE DELLA SERA
Una cena e qualche idea
In occasione della festa nazionale, il signor Perdrix (Antoine), capo ufficio del signor Patissot, fu nominato cavaliere della Legione d’onore. Contava trent’anni di servizio sotto i regimi precedenti e dieci anni dall’istituzione dell’attuale governo. I suoi dipendenti, pur mormorando un po’ di essere così ricompensati nella persona del loro capo, considerarono opportuno offrirgli una croce arricchita di falsi diamanti; e il nuovo cavaliere, non volendo restare indietro, li invitò tutti a cena la domenica successiva, nella sua proprietà ad Asnières.
La casa, illuminata con ornamenti moreschi, aveva l’aspetto di un caffè-concerto, ma la sua posizione le dava valore, perché la linea ferroviaria, tagliando il giardino in tutta la sua larghezza, passava a 20 metri dalla scala circolare esterna che si concludeva sul terrazzo d’accesso al portone principale della casa. Al centro di una aiuola verde, una vasca di foggia romana in cemento conteneva dei pesci rossi e un getto d’acqua, del tutto simile a una siringa, a tratti lanciava in aria microscopici arcobaleni, di cui i visitatori si meravigliavano. L’alimentazione di questo irrigatore era la preoccupazione costante del signor Perdrix, che a volte si alzava alle cinque del mattino per riempire il serbatoio. In maniche di camicia, con la sua gran pancia straripante dalle mutande, pompava ostinatamente, per avere, al suo ritorno dall’ufficio, la soddisfazione di lasciare scorrere le grandi acque e immaginare che la freschezza si diffondesse nel giardino.
La sera della cena ufficiale, tutti gli ospiti, uno dopo l’altro, andarono in estasi per le condizioni ideali della tenuta, e ogni volta che sentivano, in lontananza, arrivare un treno, il signor Perdrix annunciava loro la sua destinazione: Saint-Germain, le Havre, Cherbourg o Dieppe, e, per scherzo, facevano segnali ai viaggiatori che si affacciavano dai finestrini. L’intero ufficio era lì. C’era per primo il signor Capitaine, vicecapo; il signor Patissot, l’impiegato più anziano; poi i signori De Sombreterre e Vallin, giovani impiegati eleganti, che venivano in ufficio con gran comodo; infine, il signor Rade, famoso in tutto il ministero per le folli dottrine che metteva in mostra, e lo spedizioniere, signor Boivin.
Il signor Rade passava per un tipo originale. Alcuni lo consideravano un fantasioso o un ideologo; altri un rivoluzionario; tutti però erano d’accordo che fosse uno alquanto goffo. Già anziano, magro e basso, con un occhio vivace e lunghi capelli bianchi, aveva professato per tutta la vita il più profondo disprezzo per il lavoro amministrativo. Setacciatore di libri e grande lettore, di natura sempre ribelle a tutto, ricercatore della verità e sprezzante dei pregiudizi comuni, aveva un modo diretto e paradossale di esprimere le proprie opinioni tanto da chiudere la bocca agli imbecilli soddisfatti e a quelli scontenti senza sapere perché. Di lui dicevano: «Questo vecchio pazzo di Rade», oppure: «Questo Rade senza cervello»; e la lentezza del suo avanzamento di carriera sembrava dare ragione ai mediocri “parvenu” contro di lui. L’indipendenza della sua parola faceva spesso tremare i suoi colleghi, che si chiedevano con terrore come avesse potuto ancora conservare il suo posto di lavoro.
Appena furono a tavola, il signor Perdrix, in un breve e sentito discorso, ringraziò i suoi “collaboratori”, promettendo loro la sua protezione tanto più efficace man mano che fosse cresciuta la sua autorità, e concluse con una commossa arringa per ringraziare e glorificare il governo liberale e giusto, che sapeva ricercare il merito fra gli umili. Il signor Capitaine, vicecapo, rispose a nome dell’ufficio: si felicitò, si congratulò, si inchinò, si esaltò e decantò le lodi di tutti. E un applauso frenetico accolse questi due pezzi di eloquenza. Dopo di che si cominciò sul serio a mangiare.
Tutto andò bene fino al dessert, l’esiguità di parole non infastidì nessuno. Ma, al caffè, una questione sollevata inaspettatamente scatenò il signor Rade, che iniziò ad oltrepassare il limite. Si stava parlando d’amore, con naturalezza, e un soffio di cavalleria inebriava questa sala di burocrati: si vantava con esaltazione la bellezza superiore della donna, la sua delicatezza d’animo, la sua attitudine per le cose squisite, la certezza del suo giudizio e la delicatezza dei suoi sentimenti. Il signor Rade, iniziò a reclamare, rifiutando decisamente al sesso qualificato come “bello” tutte le qualità che gli venivano attribuite; e, di fronte all’indignazione generale, si richiamò a degli autori qualificati:
«Schopenhauer, signori, Schopenhauer, un grande filosofo che la Germania venera. Ecco cosa dice: “Era necessario che l’intelligenza dell’uomo fosse tanto oscurata dall’amore così da chiamare bello questo sesso di piccola taglia, spalle strette, fianchi larghi e gambe curve? Tutta la sua bellezza, infatti, sta nell’istinto dell’amore. Invece di definirlo bello, sarebbe stato più corretto definirlo sgradevole. Le donne non hanno né sentimento, né intelligenza per la musica, così come per la poesia o per le arti plastiche; ciò per loro non è altro che cantilena, puro pretesto, pura affettazione sfruttata dal loro desiderio di piacere”».
«L’uomo che l’ha detto è uno sciocco», dichiarò il signor de Sombreterre.
M. Rade, sorridendo, continuò:
«E Rousseau, signore? Ecco la sua opinione:
“Le donne, in generale, non amano nessuna arte, non si distinguono una dall’altra e non hanno alcuna genialità”».
Il signor de Sombreterre alzò le spalle con disprezzo:
«Rousseau è stupido come l’altro, tutto qui».
Il signor Rade continuò ancora a sorridere:
«E Lord Byron, che nondimeno amava le donne, signore? Questo è ciò che disse:
“Dovrebbero essere ben nutrite e ben vestite, ma non mescolate con la società. Dovrebbero anche essere istruite in religione, ma ignorare la poesia e la politica, leggere solo libri religiosi e di cucina”».
M. Rade continuò:
«Vedete, signori, studiano tutte pittura e musica. Non ce n’è una, tuttavia, che abbia realizzato un buon dipinto o un’opera notevole! Perché, signori? Perché sono il “sexus sequior”, il secondo sesso a tutti gli effetti, fatto per stare in disparte e in secondo piano».
Il signor Patissot si arrabbiò:
«E Mme Sand, signore?».
«Un’eccezione, signore, un’eccezione. Vorrei citare ancora un passaggio di un altro grande filosofo, questo però inglese: Herbert Spencer. Ecco: “Ogni sesso è capace, sotto l’influenza di stimolanti particolari, di manifestare facoltà normalmente riservate all’altro. Così, per prendere un caso estremo, una stimolazione speciale può far sì che il latte possa essere somministrato dal seno degli uomini. Si è visto, durante le carestie: bambini piccoli privati della madre, salvati in questo modo. Non includiamo, tuttavia, questa facoltà di avere latte tra il numero di attributi del maschio. Allo stesso modo, l’intelligenza femminile che, in alcuni casi, darà prodotti superiori, dovrebbe essere trascurata nel conto della natura femminile, come fattore sociale”…».
M. Patissot, in tutto e per tutto, ferito nel carattere cavalleresco che gli era proprio, dichiarò:
«Lei non è francese, signore. La galanteria francese è una forma di patriottismo».
Il signor Rade raccolse la palla.
«Ho pochissimo patriottismo, signore, il meno possibile».
Il freddo si diffuse fra i presenti, ma lui continuò tranquillamente:
«Siete d’accordo con me che la guerra sia una cosa mostruosa; che questa consuetudine di massacrare i popoli costituisca uno stato permanente di barbarie; che è odioso, dal momento che l’unico vero bene è la “vita”, vedere i governi, il cui dovere è di proteggere l’esistenza dei loro sudditi, cercare costantemente mezzi di distruzione? Sì, non è vero?
Ebbene, se la guerra è una cosa orribile, non sarebbe il patriottismo l’idea madre che lo sostiene? Quando un assassino uccide, ha un solo pensiero, ed è quello di rubare. Quando un brav’uomo, con colpi di baionetta, uccide un altro uomo onesto, padre di famiglia o forse un grande artista, a quale pensiero obbedisce?».
Tutti si sentirono profondamente feriti.
«Quando si pensano delle cose del genere, non si dicono in società».
Il signor Patissot continuò:
«Tuttavia, signore, ci sono principi che tutte le persone oneste riconoscono».
Il signor Rade chiese:
«Quali?».
Allorché, solennemente, M. Patissot pronunciò:
«Moralità, signore».
Il signor Rade, raggiante, esclamò:
«Solo un esempio, signori, un esempio molto piccolo. Cosa ne pensate dei signori con berretti di seta che sui boulevards esterni fanno il bel lavoro che conoscete e che si guadagnano da vivere?».
Un broncio di disgusto attraversò il tavolo:
«Bene! Signori, solo un secolo fa, quando un gentiluomo elegante, molto permaloso sul punto dell’onore, aveva per… amica … una “signora molto bella e onesta di alto lignaggio”, stava benissimo a vivere a sue spese, signori, e persino di rovinarla del tutto. Si trovava questo gioco affascinante. Quindi i principi della moralità non sono fissi… e poi …».
Il signor Perdrix, visibilmente imbarazzato, lo fermò:
«Sta minando le fondamenta della società, signor Rade, occorre sempre avere dei principi. Quindi, in politica, ecco il signor de Sombreterre che è un legittimista, il signor Vallin orleanista, il signor Patissot e io repubblicani, abbiamo principi molto diversi, non è vero? Eppure, noi ci intendiamo molto bene, andiamo d’accordo proprio perché li abbiamo, questi principi».
Ma il signor Rade esclamò:
«Anche io ho dei principi, signori, e ne ho di molto solidi».
Il signor Patissot alzò la testa e, freddamente:
«Sarei felice di conoscerli, signore».
M. Rade non si fece pregare:
«Eccoli, signore:
1° principio. – Il governo di uno solo è una mostruosità.
2° principio. – Il suffragio ristretto [limitato cioè soltanto ad una parte dei cittadini] è un’ingiustizia.
3° principio. – Il suffragio universale è stupidità.
1° – Infatti, consegnare milioni di uomini, intelligenze d’élite, scienziati, persino geni, al capriccio, al volere di un essere che, in un momento di allegria, di follia, di ubriachezza o di eccitazione amorosa, non esiterà a sacrificare tutto per la sua fantasia esaltata, dilapiderà le ricchezze del paese dolorosamente accumulate da ciascuno, farà ammassare migliaia di uomini da fare a pezzi sui campi di battaglia, ecc., ecc., a me sembra – a me, che sono un semplice ragionatore – un’aberrazione mostruosa.
2° – Ma pur ammettendo che il paese debba governarsi da sé stesso, escludendo con un pretesto sempre discutibile una parte dei cittadini dell’amministrazione degli affari pubblici, è un’ingiustizia così evidente, che mi sembra inutile discuterne ulteriormente.
3° – Rimane il suffragio universale. Voi siete d’accordo con me sul fatto che gli uomini di ingegno sono rari, vero? Per essere larghi, ammettiamo che al momento in Francia ce ne siano cinque. Aggiungiamo ancora, per essere più larghi, duecento uomini di grande talento, mille altri possessori di talenti vari, e diecimila uomini superiori, in un modo qualunque. Ecco uno stato maggiore di undicimiladuecentocinque dotati di spirito. Dopo di che voi avete di fronte l’esercito dei mediocri, ai quali segue la moltitudine degli imbecilli. Dato che il mediocre e lo sciocco costituiscono sempre l’immensa maggioranza, è inaccettabile che possano eleggere un governo intelligente.
Per essere onesti, aggiungerei che, logicamente, il suffragio universale mi sembra l’unico principio ammissibile, ma che è inapplicabile, ecco perché.
Far concorrere al governo tutta la linfa vitale di un Paese, rappresentarne tutti gli interessi, tenendo conto di tutti i diritti, è un sogno ideale, ma poco pratico, perché l’unica forza che si può misurare è proprio quella che dovrebbe essere la più trascurata, la forza insignificante, il numero.
Secondo il vostro metodo, il numero costituito da chi non è intelligente ha la prevalenza sull’ingegno, sul sapere, su tutte le conoscenze acquisite, sulla ricchezza, sull’industria, ecc. Quando potrete dare a un membro dell’Istituzione diecimila voti contro uno allo straccivendolo, cento voti al grande proprietario terriero contro dieci voti al suo contadino, avrete grosso modo bilanciato le forze e ottenuto una rappresentanza nazionale che riprodurrà veramente tutte le potenzialità della nazione. Ma io vi sfido bene a farlo.
Ecco le mie conclusioni: in passato, quando non si poteva esercitare nessuna professione, si faceva il fotografo; oggigiorno si diventa membri del Parlamento. Un potere così composto sarà sempre deplorevolmente incapace; ma incapace di nuocere quanto incapace di fare il bene. Un tiranno, al contrario, se è stupido, può fare molto male e, se è intelligente (cosa infinitamente rara), molto bene.
Su queste forme di governo non parlo; e mi dichiaro anarchico, vale a dire sostenitore del potere più cancellato, più insensibile, più liberale nel senso ampio del termine, e allo stesso tempo rivoluzionario, cioè l’eterno nemico di questo stesso potere, che comunque non può essere che assolutamente difettoso. Ecco.
Grida di indignazione si levarono intorno al tavolo e tutti, legittimisti, orleanisti, repubblicani per necessità, si infuocarono di rabbia. Il signor Patissot, in particolare, stava soffocando e, rivolgendosi al signor Rade:
«Allora, signore, lei non crede a niente».
L’altro gli rispose semplicemente:
«No signore».
La collera che suscitò fra tutti gli invitati impedì al signor Rade di continuare, e il signor Perdrix, ridiventando capo, chiuse la discussione.
«Basta, Signori, per favore. Ognuno di noi ha la propria opinione, non è vero? E non siamo disposti a cambiarla».
Ognuno approvò quello che considerarono un giusto intervento. Ma il signor Rade, ancora in rivolta, volle avere l’ultima parola.
«Eppure, io ho una morale», disse, «È molto semplice e sempre applicabile; una frase la enuncia, eccola: “Non fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi”. Io vi sfido a metterla in dubbio, mentre con tre ragionamenti io mi impegno a demolire il più sacro dei vostri principi».
Questa volta non risposero affatto. Ma mentre tornavamo la sera a due a due, ciascuno disse al suo compagno:
«No, davvero il signor Rade sta andando troppo oltre. Ha sicuramente un colpo di martello. Dovremmo nominarlo sottocapo a Charenton».
IMMAGINE DI APERTURA di Oberholster Venita da Pixabay